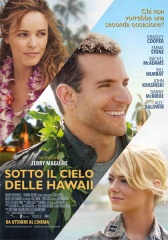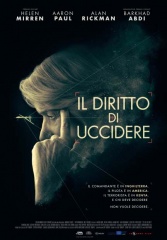|
|
IL MERCANTE DI VENEZIA: UN CONTEMPORANEO SHAKESPEARIANO
âQuando ho letto per la prima volta il Mercante di Venezia ho pensato fosse la storia di persone, né buone né cattive, che le circostanze della vita e gli scherzi del destino portano in rotta di collisione. I personaggi mi sono sembrati vulnerabili ed egoisti al tempo stesso, come ognuno di noi. Se riusciamo ad andare al di là delle apparenze, senza pregiudizi, scopriamo che per società , cultura e situazioni in cui si trovano, i protagonisti non hanno alternative e non possono agire diversamente. Sono intrappolati nel mondo in cui vivono, esattamente come noiâ¦.â
Il regista Michael Radford
(The Merchant of Venice, GRAN BRETAGNA/ITALIA/USA 2004; drammatico; Durata: 124â; Produz.: Spice Factory; Shylock Trading Ltd.; Navidi Wilde Productions; Avenue Pictures; De Luxe Production; Istituto Luce; Dania Film; Immagine e Cinema; Distribuz.: Arclight Films International/Istituto Luce S.p.a.)

|
Titolo in italiano: Il mercante di Venezia
Titolo in lingua originale:
The Merchant of Venice
Anno di produzione:
2004
Anno di uscita:
2004
Regia: Michael Radford
Sceneggiatura:
Michael Radford
Soggetto: Dallâopera teatrale di William Shakespeare
Cast: Al Pacino (Shylock)
Jeremy Irons (Antonio)
Joseph Fiennes (Bassano)
Lynn Collins (Porzia)
Charlie Cox (Lorenzo)
Mackenzie Crook (Lancillotto Gobbo)
Allan Corduner (Tubal)
Gregory Fisher (Solanio)
Kris Marshall (Graziano)
Zuleikha Robinson (Jessica)
Tony Schiena (Leonardo)
John Sessions (Salerio)
Musica: Jocelyn Pook
Costumi: Sammy Sheldon
Scenografia: Bruno Rubeo
Fotografia: Benoit Delhomme AFC
Scheda film aggiornata al:
25 Novembre 2012
|
Sinossi:
âVenezia, sedicesimo secolo. Bassanio chiede al mercante Antonio 3000 ducati per corteggiare Porzia, ereditiera di Belmonte. Antonio è ricco, ma i suoi soldi sono investiti nelle navi ancora in viaggio. Per accontentare Bassanio, a cui è legato da grandissimo affetto, si rivolge allâebreo Shylock, che attende da tempo lâoccasione per vendicarsi delle umiliazioni subite: a Venezia, per gli ebrei vige il coprifuoco, non possono circolare liberamente di notte e un enorme lucchetto sbarra le porte del ghetto. Shylock serba almeno due motivi per odiare Antonio: per lâemarginazione della comunità ebraica e perché in passato si è beffato dei suoi affari, prestando i soldi senza interessi. Ecco quindi la richiesta capestro: entro tre mesi, qualora la somma non sia pagata, Shylock avrà in cambio una libbra di carne del corpo di Antonio. Bassanio sconsiglia Antonio di accettare. Poi capitola, pensando che lâamico ha enormi ricchezze in mare. Accompagnato da Graziano, parte per raggiungere lâamata signora di Belmonte.
Porzia, bella quanto virtuosa, secondo il volere paterno non può sposare nessuno, se non il valoroso che supererà la prova dei tre scrigni. Mentre i corteggiatori falliscono uno dopo lâaltro, Bassanio non si lascia ingannare e conquista la mano della giovane. Intanto la sfortuna si accanisce su Shylock: sua figlia non è solo scappata con Lorenzo, un cristiano, ma gli ha anche sottratto dei soldi per la fuga. Dopo poche ore però gli arriva la buona notizia: le navi di Antonio hanno fatto naufragio e lui non può pagare il debito come promesso.
Le parti in causa si riuniscono davanti al Doge di Venezia. Bassanio corre a sostenere lâamico. Shylock, irremovibile, pretende la âsuaâ libbra di carne. Il destino di Antonio sembra segnato. Tuttavia Porzia, che rivuole Bassanio accanto a sé, abbandona Belmonte e arriva a Venezia Travestita da avvocato. Intrepida, difende carne e onore del mercante attraverso un cavillo giuridico: Shylock dovrà tagliare dal corpo di Antonio una sola libbra, né più né meno, senza spargere neanche una goccia di sangue. Altrimenti sarà giustiziato per attentato alla vita di un veneziano come prevede la legge. Shylock capisce lâantifona e, nonostante il desiderio di vendetta sia tuttâaltro che placato, si tira indietro, cosa che non è prevista ed è soggetta a sanzioni, addirittura a costo della vita. Il Doge però lo grazia e gli confisca i beni, che vengono divisi tra il mercante e la città . Antonio, le cui navi sono tornate in porto miracolosamente senza danni, rinuncia ai soldi a condizione che Shylock si faccia cristiano e lasci quello che resta del suo patrimonio alla figlia e al genero Lorenzoâ.
Dal Press-Book Il mercante di Venezia
Commento critico (a cura di Patrizia Ferretti)
|
 Il GRANDE SCHERMO COME PALCOSCENICO DâONORE PER UN DRAMMA UMANO DâALTRI TEMPI, EPPURE PER CERTI VERSI COSIâ FAMILIARE: SCHEGGE DI RABBIA, INTOLLERANZA E VENDETTA, SOLITUDINE E SOFFERENZA COMPRESSA O ESPLOSA. AL PACINO DETIENE LâEPICENTRO EMOZIONALE CON LâINTRIGANTE E POTENTE RITRATTO DELLâUSURAIO EBREO SHYLOCK.
Il GRANDE SCHERMO COME PALCOSCENICO DâONORE PER UN DRAMMA UMANO DâALTRI TEMPI, EPPURE PER CERTI VERSI COSIâ FAMILIARE: SCHEGGE DI RABBIA, INTOLLERANZA E VENDETTA, SOLITUDINE E SOFFERENZA COMPRESSA O ESPLOSA. AL PACINO DETIENE LâEPICENTRO EMOZIONALE CON LâINTRIGANTE E POTENTE RITRATTO DELLâUSURAIO EBREO SHYLOCK.
Con Il Mercante di Venezia di Michael Radford ci si può anche dimenticare di essere al cinema e avere lâillusione di essere di fronte ad un sontuoso e particolarmente suggestivo palcoscenico, più che davanti al grande schermo. Ma se la preoccupazione di Radford volgeva allâambizione di veder apprezzato il suo Mercante come film e non come piéce teatrale, crediamo che possa dirsi rasserenato. Questo Mercante cinematografico evita di proposito stravolgimenti e si limita piuttosto alla valorizzazione del soggetto originale, evidenziandone i tratti di grande umanità , universali e senza tempo, facendoci scoprire che, come dichiarato dallo stesso Radford, âin 400 anni la natura degli esseri umani non è affatto |
|
 cambiataâ, e per di più, intrappolata in beghe analoghe a quelle della contemporaneità , intolleranza religiosa e conseguenti faide condite di inutili e devastanti vendette in testa. Per concretizzare unâoperazione di questo genere, Radford sapeva di aver assolutamente bisogno di un grande attore e la scelta di Al Pacino come interprete protagonista per lâebreo Shylock non poteva essere più calzante. Lo conferma la straordinaria levatura della performance, alimentata peraltro dallâamore dichiarato dallâattore per il teatro e per Shakespeare, senza contare lâimportante precedente che lo ha già visto interprete ed esordiente regista di un film ispirato alla storia di Riccardo III (Looking for Richard - Riccardo III, un uomo, un Re), film sul teatro e la psicanalisi, o, se si preferisce, âfilm inchiesta sullâeredità shakespeariana nel mondo contemporaneoâ, presentato con successo al Festival di Cannes nel 1996.
cambiataâ, e per di più, intrappolata in beghe analoghe a quelle della contemporaneità , intolleranza religiosa e conseguenti faide condite di inutili e devastanti vendette in testa. Per concretizzare unâoperazione di questo genere, Radford sapeva di aver assolutamente bisogno di un grande attore e la scelta di Al Pacino come interprete protagonista per lâebreo Shylock non poteva essere più calzante. Lo conferma la straordinaria levatura della performance, alimentata peraltro dallâamore dichiarato dallâattore per il teatro e per Shakespeare, senza contare lâimportante precedente che lo ha già visto interprete ed esordiente regista di un film ispirato alla storia di Riccardo III (Looking for Richard - Riccardo III, un uomo, un Re), film sul teatro e la psicanalisi, o, se si preferisce, âfilm inchiesta sullâeredità shakespeariana nel mondo contemporaneoâ, presentato con successo al Festival di Cannes nel 1996.
Amato, ma considerato per lo più âletteratura mortaâ e per questo innumerevoli volte rivisitato e corretto |
|
 con lâintento di renderlo più vivo e vicino, Shakespeare aveva anche bisogno dellâomaggio sincero e rigorosamente fedele di un regista come Radford, che lo ripropone dunque rispettosamente così quale è, con accentazioni emozionali estremamente variegate e non sempre necessariamente prorompenti, perché, per scelta, ha ritenuto già incisivo ed eloquente il sottotesto del non detto, per il resto, si è limitato a trasporre la scrittura del mitico drammaturgo inglese nella corrente lingua parlata dai personaggi nella vita di tutti i giorni, protagonisti di splendide scenografie che ai lirici scorci dei calle lagunari affiancano sontuosi interni di palazzi, con fotogrammi amorevolmente ârubatiâ alla pittura veneta dellâepoca. Chi non ha presente le affollate âbalconateâ dipinte da Veronese ?
con lâintento di renderlo più vivo e vicino, Shakespeare aveva anche bisogno dellâomaggio sincero e rigorosamente fedele di un regista come Radford, che lo ripropone dunque rispettosamente così quale è, con accentazioni emozionali estremamente variegate e non sempre necessariamente prorompenti, perché, per scelta, ha ritenuto già incisivo ed eloquente il sottotesto del non detto, per il resto, si è limitato a trasporre la scrittura del mitico drammaturgo inglese nella corrente lingua parlata dai personaggi nella vita di tutti i giorni, protagonisti di splendide scenografie che ai lirici scorci dei calle lagunari affiancano sontuosi interni di palazzi, con fotogrammi amorevolmente ârubatiâ alla pittura veneta dellâepoca. Chi non ha presente le affollate âbalconateâ dipinte da Veronese ?
Concessione del tutto personale del regista a se stesso, il primo quarto dâora, reinventato per dotare la sua trasposizione cinematografica dellâunica cosa mancante alla piéce teatrale di Shakespare: il background dei protagonisti, non indispensabile al |
|
 teatro quanto invece fondamentale per il cinema. Radford traccia allora alcune pennellate essenziali, veloci ma incisive e ad ampio spettro di significato per lo svolgimento della storia e lâapprofondimento dei personaggi e delle loro azioni. Ed ecco che, quasi rincorrendosi lâun lâaltro, compaiono primi piani della serratura di un cancello che chiude lâaccesso alla città : è il ghetto che Venezia ha riservato agli ebrei dopo una certa ora alla sera; primi piani al ralenti di una folla scalmanata colta in furiose rimostranze contro âlâusuraâ, antitetica ai principi cristiani. E ancora primi piani di uno sputo dâinsulto contro âlâusuraioâ per eccellenza, lâebreo Shylock, ed altri primi piani di libri che bruciano o di acque intensamente chiaroscurate che riflettono un baluginare di flebili luci tra i calle nellâoscurità della notte. Un amore per il dettaglio-indizio, unâistantanea dellâatmosfera dellâepoca, con le sue annose problematiche, anche in questo caso, come in altri soggetti in
teatro quanto invece fondamentale per il cinema. Radford traccia allora alcune pennellate essenziali, veloci ma incisive e ad ampio spettro di significato per lo svolgimento della storia e lâapprofondimento dei personaggi e delle loro azioni. Ed ecco che, quasi rincorrendosi lâun lâaltro, compaiono primi piani della serratura di un cancello che chiude lâaccesso alla città : è il ghetto che Venezia ha riservato agli ebrei dopo una certa ora alla sera; primi piani al ralenti di una folla scalmanata colta in furiose rimostranze contro âlâusuraâ, antitetica ai principi cristiani. E ancora primi piani di uno sputo dâinsulto contro âlâusuraioâ per eccellenza, lâebreo Shylock, ed altri primi piani di libri che bruciano o di acque intensamente chiaroscurate che riflettono un baluginare di flebili luci tra i calle nellâoscurità della notte. Un amore per il dettaglio-indizio, unâistantanea dellâatmosfera dellâepoca, con le sue annose problematiche, anche in questo caso, come in altri soggetti in |
|
 qualche modo classici, prezioso spunto di riflessione per la contemporaneità , come del resto sottolineato dallo stesso Radford (cfr. la voce Commenti del regista in questa stessa scheda). Una sorta di prologo volto a focalizzare la connotazione del ghetto per gli ebrei previsto per legge dalla città di Venezia nel XVI secolo: è sufficiente a delineare il clima umiliante che vi si respira e a capire, se non proprio a giustificare, ciò che spingerà lâusuraio ebreo Shylock a comportarsi in un modo altrimenti incomprensibile senza ridurlo a un essere follemente spietato. Shylock ha una figlia, la moglie è morta e ha dunque alle spalle una vita dura e sofferta che il clima sociale dellâepoca non gli ha certo alleviato. âLa sua è dunque una psiche triste, disperataâ, così come rimarcato - in conferenza stampa alla 61a Mostra Internazionale dâArte Cinematografica al Lido di Venezia dove Il mercante di Venezia è
qualche modo classici, prezioso spunto di riflessione per la contemporaneità , come del resto sottolineato dallo stesso Radford (cfr. la voce Commenti del regista in questa stessa scheda). Una sorta di prologo volto a focalizzare la connotazione del ghetto per gli ebrei previsto per legge dalla città di Venezia nel XVI secolo: è sufficiente a delineare il clima umiliante che vi si respira e a capire, se non proprio a giustificare, ciò che spingerà lâusuraio ebreo Shylock a comportarsi in un modo altrimenti incomprensibile senza ridurlo a un essere follemente spietato. Shylock ha una figlia, la moglie è morta e ha dunque alle spalle una vita dura e sofferta che il clima sociale dellâepoca non gli ha certo alleviato. âLa sua è dunque una psiche triste, disperataâ, così come rimarcato - in conferenza stampa alla 61a Mostra Internazionale dâArte Cinematografica al Lido di Venezia dove Il mercante di Venezia è |
|
 stato presentato in anteprima - dallo stesso Pacino, dicendosi orgoglioso di aver accettato il ruolo in quanto âcapace di catturare (appunto), una condizione umana particolareâ, e dunque in quanto âpersonaggio che poteva riflettere una esperienza umanaâ. Ed è anche ciò che porta lo spettatore a nutrire nei confronti del personaggio più compassione che odio.
stato presentato in anteprima - dallo stesso Pacino, dicendosi orgoglioso di aver accettato il ruolo in quanto âcapace di catturare (appunto), una condizione umana particolareâ, e dunque in quanto âpersonaggio che poteva riflettere una esperienza umanaâ. Ed è anche ciò che porta lo spettatore a nutrire nei confronti del personaggio più compassione che odio.
Un prologo personalizzato, quanto necessario, in attesa di âaprire il sipario sul grande schermoâ, spalancando lâobiettivo della m. d. p. su scenografie ampie e splendidamente ammaliatrici che ammantano il nocciolo di un dramma umano che Al Pacino e gli altri interpreti protagonisti sfumano sottilmente pur mantenendosi spiritualmente e concretamente aderenti al testo teatrale, del quale il film ne conserva indubbiamente il respiro e lâanima.
Perfino le ultime battute prima del definitivo finale che ritraggono Shylock da solo, come invecchiato di ventâanni in un colpo, ricurvo su se stesso che guarda in silenzio centrando lâobiettivo della |
|
 m. d. p., dà lâimpressione netta di rivolgersi verso la platea, isolato in unâambientazione che se non lo è realmente, di sicuro sembra la sorella gemella di un palcoscenico teatrale vero e proprio, e su cui peraltro, forse non a caso, si chiudono le porte-sipario, prima di concedere agli ultimi fotogrammi il definitivo congedo dalla storia. Il respiro, lâimpronta sono letteralmente teatrali, e in questo si legge la insuperabile capacità e versatilità di un attore a tutto tondo come Al Pacino, che in questo caso ha toccato tutti i registri di recitazione, da quella rappresa e contenuta per i sentimenti repressi che logorano in silenzio ma erodono in profondità , alla ostinata rabbia e desiderio di vendetta urlati con una certa veemenza e rivendicati come legittima pretesa. Rabbia, tristezza e profonda solitudine, ecco i tre cardini su cui ruota lo Shylock di Al Pacino e di Radford, in uno spaccato di
m. d. p., dà lâimpressione netta di rivolgersi verso la platea, isolato in unâambientazione che se non lo è realmente, di sicuro sembra la sorella gemella di un palcoscenico teatrale vero e proprio, e su cui peraltro, forse non a caso, si chiudono le porte-sipario, prima di concedere agli ultimi fotogrammi il definitivo congedo dalla storia. Il respiro, lâimpronta sono letteralmente teatrali, e in questo si legge la insuperabile capacità e versatilità di un attore a tutto tondo come Al Pacino, che in questo caso ha toccato tutti i registri di recitazione, da quella rappresa e contenuta per i sentimenti repressi che logorano in silenzio ma erodono in profondità , alla ostinata rabbia e desiderio di vendetta urlati con una certa veemenza e rivendicati come legittima pretesa. Rabbia, tristezza e profonda solitudine, ecco i tre cardini su cui ruota lo Shylock di Al Pacino e di Radford, in uno spaccato di |
|
 umanità vera, autentica, che sfuma liricamente nel rabbioso monologo.
umanità vera, autentica, che sfuma liricamente nel rabbioso monologo.
Il che ci fa giungere alla conclusione che in fondo non esiste realmente una demarcata linea di confine tra lâattore per il teatro e lâattore per il cinema. Esiste solo il grande attore. E quando câè, si vede e si sente, e coinvolge sempre il suo pubblico, che sia a teatro o in una sala cinematografica. Così come un dramma classico della massima levatura, provvisto di interpreti alla stessa altezza, funziona sempre, a teatro come al cinema e, come in questo caso, anche senza doversi dare il disturbo di porgere per forza una rielaborazione personale in chiave moderna.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perle di sceneggiatura
âMi ha (riferito al cristiano Antonio) maltrattato, defraudato di mezzo milione, ha gioito delle mie perdite, deriso i miei profitti, disprezzato il mio popolo, ostacolato i miei affari, allontanato i miei amici, saziato i miei nemici!. Per quale ragione? Perché sono ebreo? Non ha occhi un ebreo? Non ha mani un ebreo? Organi? Consistenza? Sensi, affetti, passioni? Non si nutre dello stesso cibo? Non è ferito dalle stesse armi? Non soffre delle stesse malattie? Non è curato con gli stessi rimedi? Scaldato, agghiacciato, dallo stesso inverno, dalla stessa estate di un cristiano? E se ci pungete, non versiamo sangue? Se ci fate il solletico, non ridiamo? Se ci avvelenate, non moriamo? E se ci fate torto, non ci vendichiamo? Se siamo a voi uguali in tutto il resto, perché non assomigliate anche in questo? Se un ebreo fa torto a un cristiano, a che si riduce la sua carità ? Alla vendetta! E se fa torto a un ebreo, quale esempio elevato di sopportazione gli mostra un cristiano perfetto? Solo vendetta! Io metterò in pratica la malvagità che ci insegnate e non sarà difficile che io vada anche oltre, ben oltre lâinsegnamentoâ¦â Monologo di Shylock
Commenti del regista
â⦠Ho cercato di ricostruire un mondo quanto più vicino a quello descritto nella commedia per almeno due motivi: non mi interessava rivestire Shakespeare di abiti moderni, il cinema è un mezzo molto concreto e credo che cambiare contesto storico significhi andare verso una rielaborazione personale dellâopera. Come spettatore vorrei avere la possibilità di capire la storia da solo, senza che il regista mi comunichi qualcosa di ovvio. In secondo luogo, sono restio a contestualizzare gli oggetti, ad esempio trasformare una spada in pistola. La scrittura di Shakespeare affonda le radici in una cultura specifica: quella dellâInghilterra del XVI secolo.
Se si parte da questa premessa e si entra in sintonia con quella società , si comprende la grandezza umanistica di Shakespeare in tutta la sua universalità . E si scopre che, in quattrocento anni, la natura degli esseri umani non è affatto cambiata.
Sono convinto della forza del sottotesto, del fatto che il non detto sia più efficace di ciò che viene espresso.
Se volete ho deciso di trattare Shakespeare come Cecov: le sue opere risentono fortemente dellâambientazione storico-geografica, così come âIl mercanteâ appartiene a una determinata epoca veneziana.
Ho spesso avuto la sensazione che il lavoro di Shakespeare sia venerato ed ammirato ma nella maggior parte dei casi venga considerato letteratura âmortaâ; e cioè che tacitamente, si ritiene necessiti di qualche altro ingrediente per renderlo appetibile. Rifuggendo da un simile approccio ho pensato ai personaggi come se si trattasse di una commedia moderna. Attraverso i loro drammi ho cercato di coinvolgere lo spettatore in modo che la poesia, a volte così difficile da comprendere, diventi espressione naturale della storia. Anzi, nel fare il film, abbiamo cercato di usare la scrittura di Shakespeare come linguaggio, parlato e sentito, per permettere al pubblico di identificarsi e vivere le stesse emozioni e passioni dei personaggi.
A voi giudicare se ci siamo riusciti.â
Fedele al testo originale maâ¦:
â⦠ho fatto una doppia operazione: ho lavorato per sottrazione e aggiunto alcune cose che nel testo non câerano. Shakespeare entra nella storia a un certo punto, senza spiegare nulla. I suoi personaggi non hanno background, cosa di cui non possiamo fare a meno al cinema. I primi quindici minuti del film sono una mia invenzione⦠Shakespeare usava un linguaggio molto ricco, quasi barocco, in contrapposizione alla povertà dei mezzi scenografici del tempo. Ho immaginato un Mercante non troppo distante dal suo, come epoca e rappresentazione. Lâho ambientato nella Venezia rinascimentale, molto ricca, decadente, oscura, anche promiscua. Contemporaneamente non volevo che Belmonte fosse un posto troppo fantastico: ho pensato a una villa palladiana, sul Brenta a un giorno da Venezia. Un misto del Malcontento (interni) e Barbarigo (esterni) e ho ricostruito al computer i paesaggi che non esistono piùâ¦â.
Quanto al famoso monologo âin cui Shylock si fa portavoce della millenaria persecuzione contro gli ebreiââ¦:
âLâho lasciato praticamente intatto. Gli ebrei di allora non sono molto diversi dai musulmani di oggi. Due società che non si capiscono. Shylock e la sua gente hanno gli stessi problemi degli immigrati: cercano di preservare la propria identità e cultura in una città straniera. Shylock, non a caso, impazzisce quando scopre che la figlia vuole sposare un veneziano, bello e cristianoâ.
Morale della favola:
â⦠Shylock è stato umiliato ma spinto dalla vendetta è andato troppo lontano. Eâ preso da quello che noi inglesi, quando guidiamo la macchina, chiamiamo âla rabbia della stradaâ. Vuole uccidere. Anche gli altri hanno virtù e debolezze. Antonio è un uomo generoso ma odia gli ebrei. Eâ onesto o disonesto? Lo stesso vale per Bassanio. Eâ questo il sottotesto della storia: siamo tutti uguali. Il film che mi è venuto in mente, con grande riverenza, è Nashville di Robert Altman, in cui i personaggi non sono né buoni né cattivi. Nalla vita, a volte, siamo portati ad andare oltre, fare cose che non faremmo. I veneziani dellâepoca non erano antisemiti, erano i francescani che ce lâavevano con gli ebrei perché praticavano lâusura, li chiamavano i figli del diavolo e i poveri ci credevanoâ.
Dal Press-Book Il mercante di Venezia
Links:
Galleria Fotografica:
1
<- torna alla pagina Movies & DVD
|
|
|